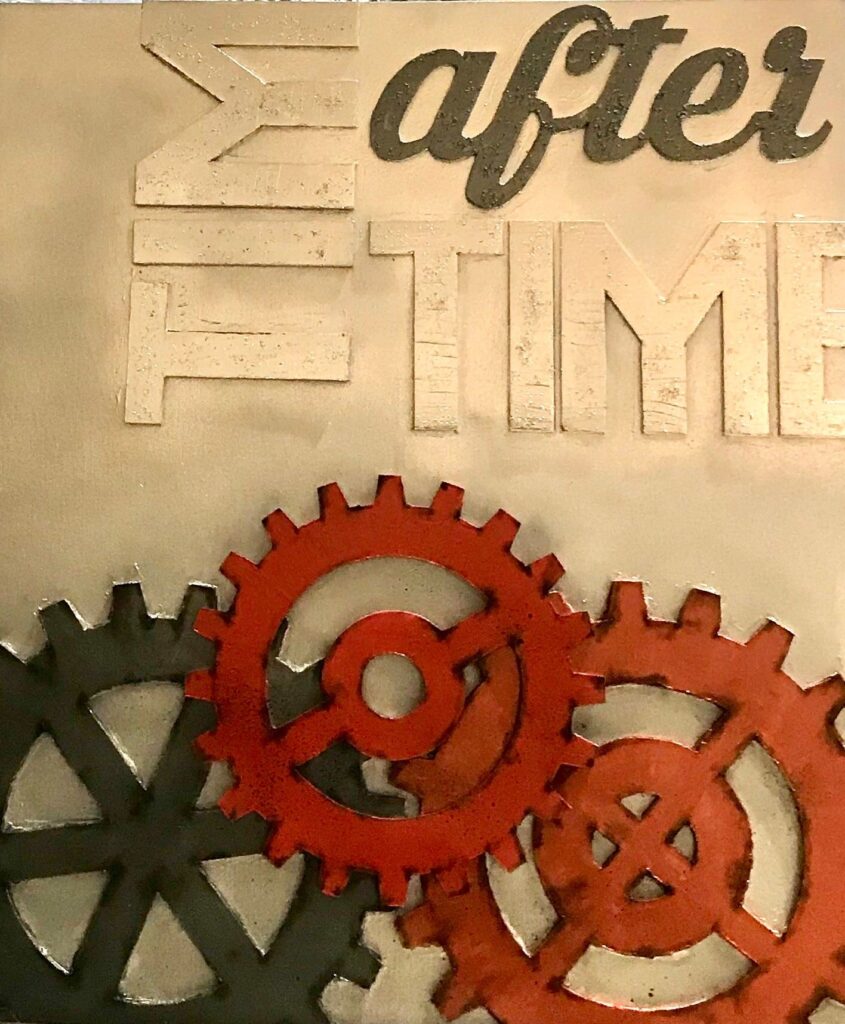Gabriele La Monica-Comunicare bene non è un costo, ma sempre un’opportunità di guadagno
Cosa accomuna la tragedia del Ponte Morandi e la querelle dei pandori di Chiara Ferragni? Se si guarda alle due vicende dal punto di vista della comunicazione, si nota come siano entrambe caratterizzate da clamorosi errori. Dopo il crollo del Ponte nessun azionista o manager ha pensato di fare un qualsiasi cenno che testimoniasse una forma, anche minima, di vicinanza. Nel caso dei Pandori, Ferragni era perfettamente a conoscenza dell’indagine dell’Antitrust. Ma invece di cavalcare la notizia quando il procedimento era ancora in corso ha preferito aspettare. Con ogni probabilità i manager delle due società hanno ascoltato il settore legale scegliendo il silenzio. Una scelta che per Ferragni poteva essere plausibile (per Genova è stato solo un ulteriore affronto alle vittime), ma che in entrambi i casi ha portato a una tempesta perfetta di critiche che ha aggravato le conseguenze reputazionali dell’evento. Questo evidenzia come la comunicazione oggi sia un passaggio essenziale per ogni azienda. Nei manuali di economia aziendale è associata al costo puro. E già questo non contribuisce a renderla simpatica. Se poi si aggiunge che comunicare comporta far conoscere qualcosa di sé, almeno nella percezione più grossolana che si può avere del concetto, questo la rende invisa ai troppi imprenditori che ancora confondono la riservatezza con l’invisibilità. Oggi l’assunto del fondatore di Mediobanca, Enrico Cuccia, secondo cui “la rassegna stampa perfetta è quella vuota” è anacronistico e sbagliato. La comunicazione aziendale si divide in interna ed esterna. La prima è imprescindibile anche per i più ossessionati dalla segretezza. Per comunicazione interna si intende il complesso di attività finalizzate a creare una rete di flussi informativi e mirate a diffondere informazioni, saperi e conoscenze e a rendere chiari e condivisi gli obiettivi di un’organizzazione complessa ai suoi dipendenti. Siamo molto oltre le circolari interne o gli avvisi in bacheca. Una inesatta o incompleta comunicazione interna è molto spesso alla base di reati colposi commessi dal dipendente, reati che comportano per l’azienda l’imputabilità ex 231. Negli oltre 20 anni della legge la lista dei reati- presupposto, ovverosia quelli che possono innescare la fattispecie, si è allargata enormemente e ogni anno diviene più nutrita. Si è passati da un nucleo originario di reati, caratterizzati da essere commessi nell’ambito di imprese svolgenti un’attività lecita, a fattispecie di reato non attinenti alla criminalità d’impresa. Per evitare che i dipendenti in buona fede possano commettere reati, la formazione e l’informazione devono essere costanti ed essere inserite in un contesto, un flusso, che il dipendente deve percepire e recepire. Se si passa alla comunicazione esterna, la situazione è spesso più drammatica. In un’era caratterizzata da web e social network, non comunicare significa semplicemente non esistere. E non esistere non significa solo fare fatica a vendere il proprio prodotto, ma anche la propria storia. E questo spesso si traduce nell’incapacità di attrarre finanziamenti differenti dal credito bancario. Tanto basterebbe a giustificare non solo un uso costante della comunicazione esterna, ma anche la formazione di una classe di dirigenti che sappia comunicare efficacemente con la stampa e tutti gli stakeholder. Spesso l’assenza di comunicazione rende inefficaci alcuni investimenti, anche molto onerosi. A cosa serve partecipare a costose fiere internazionali se ci si arriva con un abito non all’altezza? Uno spot di alcuni anni fa recitava che “la forza è nulla senza controllo”. Si può dire che la produzione senza immagine è molto più debole.
Catanese di nascita e milanese di adozione, è giornalista da quasi trent’anni dopo una laurea in giurisprudenza. Dopo un inizio da freelance e un quinquennio a Rds Radio Dimensione Suono, da vent’anni è il responsabile della redazione milanese dell’agenzia di stampa Mf Newswires. Esperto del settore bancario ha seguito da vicino le ultime scalate e anche le crisi del settore. L’esperienza universitaria, come assistente nel corso di “Sociologia della comunicazione” lo ha portato a osservare e praticare il mondo della comunicazione aziendale, imparando a conoscere, apprezzare e divulgare i comportamenti virtuosi che un’azienda deve porre in essere per prevalere e massimizzare i profitti.