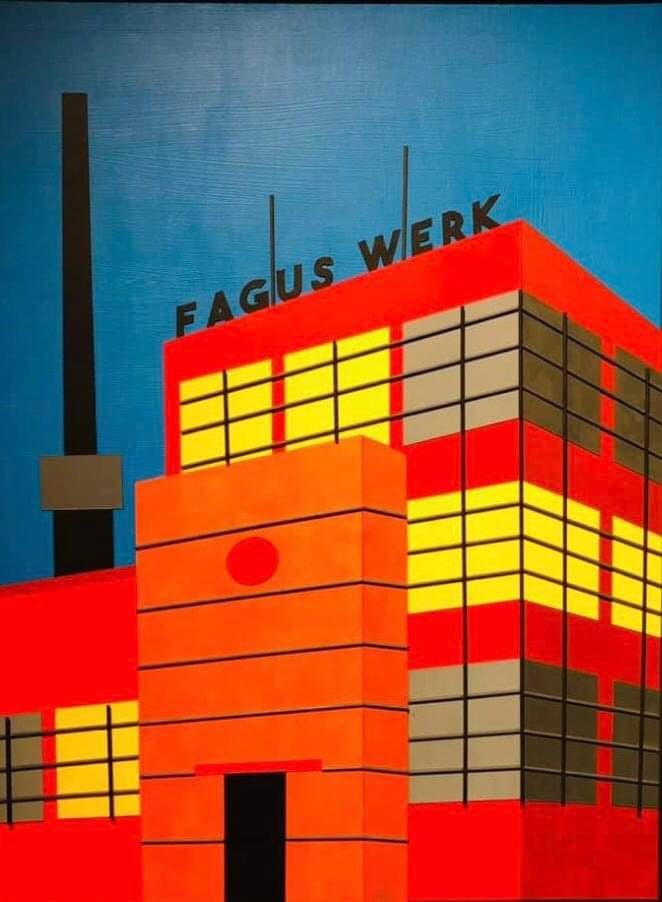Giuseppe Chisalè-La solitudine dell’imprenditore
Rappresento una famiglia che è nel ramo imprenditoriale da quattro generazioni: il capostipite fu il mio bisnonno e oggi tocca a me. Nella mia famiglia non è mai stato un problema di scelta se appartenere a questo mondo o meno, ma l’abbiamo sempre interpretata come una sorta di vocazione.
Sono cresciuto nei racconti di mio nonno sulla necessità di essere dei “bravi imprenditori” dove “il profitto” non è mai stato il metro di giudizio adottato per esserlo o meno, quanto piuttosto la necessità di esser tutti pienamente responsabilizzati sui nostri doveri sociali con chi ha creduto (e continua a credere) nel nostro progetto: i dipendenti in primis, poi i fornitori e i nostri clienti.
Ecco, forse, essere imprenditori in questo contesto storico ed economico così complicato espone spesso la categoria che rappresento a una forma di alienazione che mi piace chiamare “la solitudine dell’imprenditore”. Premetto che qualunque contesto storico ha sempre rappresentato per ogni imprenditore un banco di prova nell’interpretare velocemente le novità insite ai cambiamenti, ma volendo fare il focus sull’ultimo triennio, con una pandemia internazionale prima e una dinamica inflattiva davvero impazzita poi, fare impresa è davvero estenuante. Ma non per questo meno stimolante.
Parto sempre dal tema della responsabilità, sia personale che verso la collettività che mi sento di rappresentare e fatta dai miei dipendenti, fornitori e clienti. Noi imprenditori dobbiamo prendere decisioni spesso cruciali “al buio”, visto che non si era mai visto e immaginato, se non all’inizio del ventesimo secolo, un contesto così mutevole e fragile. E spesso queste decisioni vanno prese velocemente e senza una rete emotiva di sostegno: seppur circondati da un sistema di affetti, certe dinamiche spesso sono difficilmente comprensibili se non con chi si trova nella stessa condizione di necessità o sta vivendo (ha vissuto) esperienze imprenditoriali simili.
Quando si prende una decisione in un contesto economico così turbolento si va necessariamente a tentativi e seguendo il proprio istinto e talento, (grande o piccolo che sia), ma il dovere sociale di cui l’imprenditore si sente caricato, rischia di costringerlo in un circolo vizioso: più decisioni da prendere, più stress, meno possibilità di confrontarsi, maggiore isolamento emotivo, maggiore probabilità di fare degli errori non tanto nella intuizione, ma nell’esecuzione di una decisione.
Ecco perché ritengo molto importanti le opportunità di confronto che si possono generare a livello territoriale tra associazioni volontarie di imprese, o qualunque altra forma di dibattito pubblico o privato tra imprenditori!
Sono momenti necessari per ascoltarci reciprocamente, stimolarci, consigliarci, sostenerci e anche talvolta sfogarci su tematiche che ci accomunano e spesso che ci tormentano.
Ritengo che spesso si abbia una immagine un po’ edulcorata e naif del mondo imprenditoriale, spesso rappresentato come “un’enclave borghese” che vorrebbe difendere presunti vantaggi sociali, cristallizzati nel tempo.
Non c’è nulla di più sbagliato! L’imprenditore rischia non solo un suo capitale economico, ma anche un suo capitale umano, fatto di affetti, relazioni, reputazione ed è tendenza di ogni bravo imprenditore mettere il gruppo dei suoi stakeholders davanti a tutto e a tutti.
Mi dispiace invece constatare come gli imprenditori siano spesso lasciati al loro isolamento e non si riesca a riconoscere, prevenire ed intervenire per tempo alcuni malesseri e i frequenti “mal di pancia” che qualunque decisione aziendale comporta sullo sviluppo dell’impresa, e quindi di territorio, e quindi di un contesto sociale.
Ne ho parlato tante volte in sede di associazionismo di imprese: uno stato di crisi di una impresa è una sconfitta per tutti, non solo per l’imprenditore che ne è a capo.
Rimango allora fortemente dell’idea che solo un clima di piena cooperazione tra imprenditore, dipendenti, stakeholder e amministrazione pubblica possano creare occasioni di reciproco stimolo e ricchezza per tutti.
Ecco perché credo molto nel confronto tra imprenditore e parti sociali: la solitudine di cui ho parlato prima limita la capacità di generare idee innovative e di sviluppare strategie di crescita. Senza un ambiente di supporto e collaborazione, l’imprenditore può trovarsi “impantanato” nelle proprie paure, non riscendo a cogliere più eventuali opportunità di crescita, ma soprattutto, venendo meno a quel “dovere sociale” a cui facevo riferimento in apertura e di cui mi sento, ancora e orgogliosamente, promotore.
Genovese, classe 1968, è dal gennaio 2004 presidente e amministratore esecutivo della Giuseppe Lang arti grafiche, azienda fondata a Genova nel 1887 con il nome Tipo-litografia Fratelli Waser e poi rilevata nel 1911 dal bisnonno Giuseppe Lang, che ne era socio.
La azienda è rimasta stabilmente nelle mani della famiglia da allora, affrontando le drammatiche parentesi delle guerre mondiali e innumerevoli crisi finanziarie ed economiche.
Oggi Giuseppe rappresenta la quarta generazione.
Dal 2010 al 2014 Giuseppe è stato Presidente di sezione in Confindustria Genova.